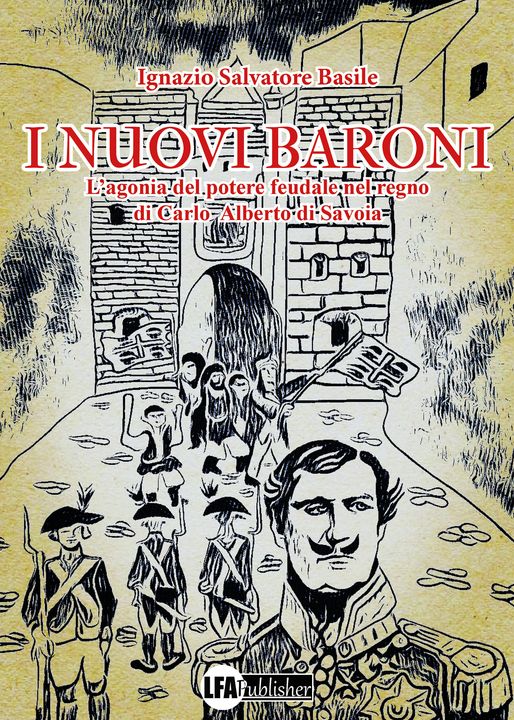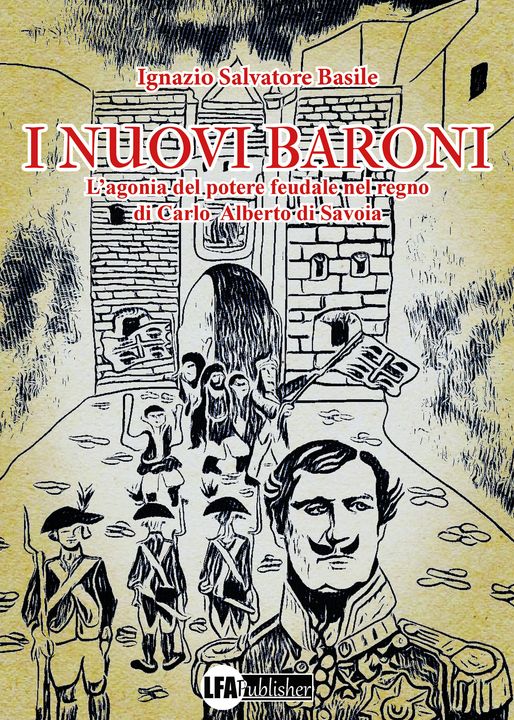In quell’anno scolastico 1970-1971 ero approdato alla terza classe dell’istituto Tecnico per Ragionieri “Leonardo da Vinci” di Cagliari.
Proprio in quell’anno mi ero accorto di avere sbagliato scuola: la Ragioneria e la Tecnica Commerciale, materie di indirizzo, mi annoiavano a morte, mentre studiavo sempre più volentieri l’italiano, la storia e le lingue straniere, il diritto e l’economia; avrei studiato anche le materie professionali, almeno per arrivare alla sufficienza.
D’altronde non è che i professori potessero ammazzarci di studio. Qualcuno l’avrebbe anche voluto (noi li chiamavamo “fascisti e reazionari”) ma ormai eravamo troppo impegnati nella lotta contro le vecchie istituzioni scolastiche e chiedevamo a gran voce di essere arbitri dei nostri destini. I nostri professori e le istituzioni più in generale, dal Preside sino al ministro della P.I. (quell’anno, se le fonti e la memoria non mi ingannano, era il democristiano Misasi), d’altro canto, si scoprirono abbastanza impreparati a fronteggiare quella protesta rumorosa e convinta.
Il terzo anno, nella Ragioneria, così come, credo, in tutti gli istituti superiori, è un anno cruciale. Intanto di solito si cambia di corso (io infatti fui trasferito dal corso F al corso D). In secondo luogo si studiano delle materie del tutto nuove.
Così fu anche per me in quell’ottobre del 1970.
I miei nuovi professori erano assai diversi tra loro. Intanto c’erano quelli delle materie così dette di indirizzo: Ragioneria e Tecnica; oggi, nella moderna ragioneria le due materie sono state unificate sotto il nome di Economia Aziendale, ma all’epoca, come dicevo, vi erano due materie e due insegnanti. Il professore di Ragioneria era un uomo tutto d’un pezzo. Si chiamava Murru. Quando entrava in classe noi ci levavamo tutti in piedi, in segno di saluto e di rispetto (ma lo facevamo per tutti i docenti indistintamente). Col braccio destro levato in aria e la mano tesa ci ordinava di sedere senza pronunciare parola. Ma i suoi occhi chiari e freddi scrutavano attenti tutta la classe; quello sguardo era eloquente più di qualunque parola, così come quel saluto solenne e ormai fuori moda: se non parlo io che sono il capo, sembrava dire il bellicoso professore di ragioneria, perché dovreste farlo voi, che siete dei poveri studenti, ancora senza arte né parte ( e chissà se mai ce l’avrete con quei cappellacci lunghi e con quelle minigonne).
Si lavorava in silenzio e sodo. Io mi ero rassegnato a occupare il primo banco (sempre per via della storia che i piccoletti dovevano stare avanti).
Da lui, oltre al saluto caratteristico ricordo altre due cose: la prima è che ripeteva spesso che i sindacati, soprattutto quelli di fede socialista, erano la rovina dell’Italia (narrava, a metà tra il serio ed il faceto, che i sindacalisti erano dappertutto e che se uno di noi, un domani, rientrando a casa, avesse scovato nell’armadio o sotto il letto un uomo, non ci sarebbe stato alcun bisogno di chiedergli i documenti: si sarebbe trattato di un sindacalista di fede socialista); la seconda era la tecnica che aveva per ricordare gli articoli del codice civile (questa tecnica mi tornò poi utile anche all’università per memorizzare i quattro codici); un giorno che ci spiegava il contratto di società, citando l’art. 2247 c.c., disse che ricordava quel numero facilmente, essendo nato nel 1922 ed essendosi poi sposato nel 1947; e faceva queste associazioni per tutti o quasi gli articoli del codice civile. Della sua materia non ricordo un beato picchio. Non mi piaceva (forse perché non mi piaceva lui; o magari, viceversa, non mi piaceva lui, perché mi era antipatica la sua materia).
Era un uomo freddo e distante; sicuramente preparato (si intuiva che nella sua materia non era uno sprovveduto), non metteva però alcuna emozione nel trasmettere la sua scienza. Quando anni dopo, sono divenuto un insegnante, ho messo l’emozione e la passione al pari con la preparazione e la conoscenza; ma io ho sempre amato le materie che ho insegnato.
E’ vero anche che i tempi sono cambiati. Oggi i giovani non accetterebbero quella severità e quella distanza glaciale che ci separava dai nostri professori!
Io pendevo dalle labbra dei miei professori perché volevo imparare da tutti e di tutto! Ed ero come una spugna, desideroso di apprendere!
Oggi i giovani hanno a portata di click, tramite il PC o il Tablet, o meglio ancora l’ I-phone e il cellulare, tutto lo scibile possibile e immaginabile in qualsiasi campo della scienza e di ogni altro campo della vita!
Altro che giornaletti e fumetti! Altro che sognare “Le Ore!” Adesso bastano tre lettere sulla barra di Google e tutto il bello e il brutto della vita ti si spalanca davanti agli occhi! Peccato che questi giovani, troppo spesso, facciano un uso distorto e superficiale di questa portentosa invenzione chiamata Internet; di questa rete infinita di autostrade e sentieri, di valli e praterie che si chiama WEB!
Io ammiro davvero l’ingegno umano! Ma ripeto ancora: meno male che gli altri uomini non sono come me! Altrimenti altro che World Wide Web! Noi saremmo ancora nelle caverne, arrostendo il frutto della caccia e nelle interminabili sere d’estate, siederemmo ancora attorno al fuoco, ad ascoltare dai poeti erranti, le vicende antiche delle nostre genti, tramandate oralmente di padre in figlio, da maestro a discente, da poeta ad allievo! Adorando la luna nelle notti di plenilunio.
Del professore di Tecnica non ricordo bene il cognome. Ricordo che la moglie era un’insegnante e che il fratello era medico sociale del Cagliari Calcio che di lì a poco avrebbe vinto lo scudetto del massimo campionato di calcio, grazie alle reti eccezionali del grande Gigi Riva.
Aveva una barca, ormeggiata in inverno a Marina Piccola (dove ormeggiano le barche da diporto dei cagliaritani facoltosi e non solo), e in estate ormeggiata in giro per il Mediterraneo. Faceva il commercialista e l’assicuratore (più il secondo che il primo, ad onor del vero). L’assicuratore marinaio aveva mangiato la foglia e doveva essersi detto nelle sue riflessioni, tra una polizza assicurativa e una manovra di trinchetto: a questi giovani qui non gli va di fare un beato cacchio; vogliono la rivoluzione, il sei politico, la promozione garantita; fanno gli scioperi, vogliono le assemblee e la pari dignità studenti-professori! Ebbene, accontentiamoli! In un discorso alquanto serio ci aveva quindi detto: se volete lavorare, io son qua! Usatemi come si usa uno strumento e farò ciò che volete!
Detto e fatto! A noi ragazzi non ci andava di far niente (io men che meno nella sua materia)! Alle ragazze sentir parlare di strumento doveva aver fatto venire in mente delle altre fantasie, dato che il professore si presentava più alla mano rispetto a quello di ragioneria. E comunque si associarono a noi maschi per non far niente.
Ricordo anche degli altri professori. Naturalmente quello di diritto e di economia, materie che amavo e che amo ancora, come ho già avuto modo di dire! Anche se non erano le mie preferite! Le materie che mi appassionavano maggiormente erano invece l’Italiano e la Storia. Le ho sempre apprezzate! Sicuramente anche per merito delle professoresse e dei professori che hanno avuto la pazienza di decifrare la mia quasi impossibile grafia, nei lunghi temi in cui sfogavo la mia verve di imberbe scrittore! E la storia? come si può non amare la storia? Come ci si può annoiare a leggere quei libri dove vengono narrate le gesta dei nostri avi? Dove ci sono scritti i segreti e le spiegazioni di ciò che fummo e le anticipazioni di ciò che saremo?
La mia professoressa del triennio si chiamava Annamaria Chessa.
Nonostante ci desse del lei (ma tutti i docenti davano del lei agli studenti nella nostra scuola) e nonostante la sua cattedra fosse distante e sopraelevata su di una imponente pedana, io la sentivo vicina; emanava una grande umanità e una notevole empatia la legava a noi studenti. Ha cercato di insegnarmi ad esercitare uno spirito critico e un’ intelligenza libera da pregiudizi; si preoccupava, oltre che dell’insegnamento, anche della formazione di noi giovani, trasmettendoci il senso del dovere anche con il suo esempio. Io credo che un buon insegnante debba prima di tutto dare il buon esempio: un cittadino si forma con l’esempio di giustizia, di lavoro, di rettitudine, di onestà, di puntualità, di disponibilità nel servizio e nella preparazione continua e ininterrotta. Il buon esempio vale più di mille parole! E lei, in questo, fu esemplare per davvero!
Mi sono ispirato anche a lei nei primi anni del mio insegnamento (anche se gli studenti mi pregavano di dargli del tu e io, dopo poco tempo, ho preso a chiamarli perfino con il nome di battesimo!).
Non si lavorò comunque molto in quei primi mesi dell’anno scolastico 1970-1971. Lo sciopero era sempre nell’aria e noi rivendicavamo il diritto di riunirci e di discutere dei problemi del mondo e non soltanto di scuola e di argomenti legati al programma.
Cominciai in quell’anno a scioperare con maggiore convinzione anche io. Nella mia scuola vi era un gruppo di organizzatori entusiasti e capaci; erano tutti ragazzi di quarta e di quinta; qualcuno era impegnato anche politicamente; molti erano semplicemente del movimento studentesco, quello non politicizzato, che si occupava soltanto dei temi della scuola, rivendicando diritti allora quasi impronunciabili: assemblee di classe, assemblee di istituto, rappresentanza nelle istituzioni, diritto a conoscere i voti, diritto di interagire e discutere alla pari con i docenti; diritto di contestare e di ribellarci; diritti, solo diritti e sempre diritti. Gli adulti furono molto pazienti con noi. Alcuni, anche fra i politici, erano perfino impauriti. Tirava una brutta aria e certi studenti sembravano non avere alcuna voglia di scherzare. Altri uomini politici erano semplicemente dei dritti: gente che aveva studiato prima e più di noi e che sapeva che se ci avessero affrontato di petto, rischiavano il tracollo; presi così, invece, di fianco, forse ci saremmo stancati prima noi! La ribellione sembrava comunque epocale! Secondo me era il prosieguo della rivoluzione dei Figli dei Fiori! Insomma avevamo scoperto che il mondo poteva essere nostro e volevamo prendercelo, tutto e subito! Chi erano quei matusa grigi e senza fantasia per impedire a noi giovani di essere noi stessi? Come potevano impedirci di vivere le nostre esperienze? E perché soltanto i ricchi potevano andare a scuola? La cultura non era forse di tutti? E il potere non doveva essere del popolo, come insegna la parola democrazia? A questi cori confusi ed indistinti, ma forti e mirati, si aggiungevano quelli delle femministe: sesso libero; no al maschilismo; il sesso ce lo vogliamo gestire da noi; abbasso i padri e i mariti padroni! A morte il paternalismo! Lavoro per tutti! Pillola, aborto e divorzio garantiti! Vogliamo la parità coi maschi! E così via gridando, manifestando e protestando!
Arrivammo così a dicembre. La resa dei conti dopo le schermaglie dell’ ennesimo autunno caldo.
Si fronteggiavano due Italie: una vecchia, rivolta al passato, appoggiata dalla Chiesa e dalla classe politica democristiana e liberale; l’altra, proiettata verso il futuro, rivolta in avanti, appoggiata dai comunisti, dai socialisti e dai radicali di Marco Pannella.
E chi può dire cosa sia meglio nel cammino dell’uomo? Non è che a forza di andare avanti finiremo col cadere in un burrone senza fondo? Cosa c’è dietro dell’angolo di questo infinito progresso, di questa ricerca senza fine, di questo spasmodico ritmo che travolge il passato ed è incentrato sul futuro, senza se e senza ma?
A gennaio, dopo le vacanze di Natale, si rientrava a scuola e si riprendeva a frequentare regolarmente.
Succedeva sempre e quell’anno 1971 non fece eccezione. Anche se occorre sottolineare che nella scuola c’era fermento anche tra i docenti, che rivendicavano degli aumenti stipendiali che dei governi fragili non erano riusciti a garantire (ricordo, oltre ai monocolore democristiani, i più frequenti quadripartiti con il PSI di Nenni e Di Martino che poi diverrà solo di Bettino Craxi, il PRI di Ugo La Malfa e di Giovanni Spadolini e il PLI di Valerio Zanone, che divennero più tardi governi di pentapartito, con l’aggiunta del Partito socialdemocratico, sino ai primi anni novanta, quando le inchieste giudiziarie di Tangentopoli spazzeranno via tutta quella classe politica) .
Sia detto per chiarezza, anche se per inciso, che dal ciclone di tangentopoli sembrò salvarsi soltanto il PCI; qualcuno pensò che il motivo stesse nel fatto che i giudici della procura di Milano e di quelle che la imitarono nell’inquisire i politici corrotti, fossero degli uomini di sinistra; ma il motivo è un altro: i comunisti, a livello nazionale, non riuscirono mai ad entrare e diedero solo degli appoggi esterni nei momenti topici della vita del Paese; il povero Aldo Moro pagò con la vita il tentativo di far sedere i comunisti ai posti di comando, nei palazzi del potere nazionale; povero Aldo Moro, chissà se voleva farli entrare per dimostrare che anche i comunisti erano corruttibili come e più degli altri politici (Enrico Berlinguer a parte), come poi dimostreranno nelle sedi del potere regionale e, più tardi, come PD anche alla guida dei governi nazionali.
In quei primi mesi del 1971, attraverso i giornali, la radio e la televisione apprendiamo dell’esistenza dei Tupamaros uruguaiani e degli Halcones messicani; Tito si reca in Vaticano da Paolo VI (primo leader comunista a visitare un papa cattolico); a proposito di comunisti, quelli cinesi di Maotzetung e Ciuenlai aprono al dialogo con gli USA con il pretesto del Ping-Pong (disciplina in cui i Cinesi sono bravissimi); si parla moltissimo in Italia anche di un colpo di stato organizzato dalla destra, su imitazione di quello avvenuto in Grecia nello stesso anno, per portare i militari al governo.
Sembra che l’anima del fallito golpe sia stato il principe Junio Valerio Borghese, un pluridecorato eroe, militare e militarista. Viene trovata anche la lista dei 500: politici, imprenditori, militari e semplici cittadini (tra cui figurano nomi che vediamo ancora adesso in TV: Berlusconi, Cicchito, Costanzo); sembra che questa lista sia legata a un certo Licio Gelli, grande maestro della massoneria, anticomunista, poeta e grande organizzatore. Si sente inoltre parlare per la prima volta di Gladio, un’organizzazione, anch’essa segreta, come la P2 di Licio Gelli, che sottotraccia deve monitorare la politica italiana, pronta ad intervenire nel caso i comunisti, con le buone (attraverso normali elezioni) o con le cattive ( Lotta Continua, Potere Operaio, le Brigate Rosse ) assumano il potere. Insomma, si vive in un gran bailamme di notizie non confermate, di sospetti, di intrighi e di misteri.
Potevo io, coi miei poveri diciassette anni, neppure compiuti, riuscire a dipanare quelle matasse aggrovigliate di complotti, di intrecci politici, di associazioni segrete, di poteri occulti, quando in realtà non avevo neppure presenti e chiari i poteri palesi e istituzionali (peraltro fragili e perfino poco autorevoli e scarsamente indipendenti in un mondo che sembrava dominato alla grande dal gigante USA)?
Infatti non li capivo. Protestavo, come tanti giovani di allora, contro la corruzione, lo strapotere democristiano, l’imperialismo americano, l’arroganza dei ricchi, le scarse opportunità offerte ai figli dei proletari, lo sfruttamento degli operai, la scarsa libertà, il perbenismo interessato (come cantava il grande Francesco Guccini), la voglia e il desiderio di un mondo diverso, con più uguaglianza, con una più equa distribuzione della ricchezza, con più lavoro e più benessere per tutti. Protestavo perché intuivo, più che capire, che era il momento di far sentire la nostra voce, la voce dei deboli, di coloro che erano stati zitti per lunghi anni, forse per decenni o addirittura per secoli!
Ma il 1968 ( e gli anni di riverbero e prosecuzione) non sarà stato il prosieguo dei moti del 1848? Ci sarà un filo comune che lega le ribellioni di ogni tempo contro il potere costituito, contro ogni forma di oppressione, contro chi si arroga il diritto di tenere per sé tutta la ricchezza che si produce, prima nelle terre e nelle miniere, poi nelle industrie e nelle fabbriche?
Forse la vita è soltanto un susseguirsi di sopraffazioni cui fanno seguito delle illusioni, dei sogni, delle ribellioni, delle piccole, provvisorie conquiste; e poi, inevitabile, subentra nuovamente la repressione che si riprende, con gli interessi e la vendetta, quello che ha dovuto cedere obtorto collo!!!
Mi sembra di averlo letto, forse nei libri di storia; o in qualche romanzo; o forse nei giornali. O magari l’ho inventato io! Però mi sembra che sia proprio così!
E a pensarci bene, certi misteri e certi intrecci italiani non li ho capiti neppure oggi che negli -anta ci sono da molti decenni!
A giugno arrivò un’altra promozione diretta. Promosso alla quarta classe, diceva la pagella! Potrà sembrare buffo ma leggendo quella pagella io mi chiesi se sarei stato all’altezza di quella promozione! Sarei stato capace di organizzare gli scioperi, di condurre dei dibattiti, di affrontare il preside e i professori con il piglio che esercitavano quei fratelli maggiori che andavano diplomandosi?
Dicono che per maturare, ciascuno di noi debba percorrere i suoi sentieri; e dicono anche che questi sentieri siano sempre costellati di errori, ingenuità e fraintendimenti, frutto della nostra inesperienza, della nostra spavalderia, del nostro carattere, più o meno forte, più o meno profondo, più o meno riflessivo; frutto della nostra cifra intellettiva, ma anche di ciò che abbiamo vissuto, del latte che abbiamo succhiato, dell’aria che abbiamo respirato, della cultura di cui siamo stati imbevuti sin dai nostri primi passi sulla terra. Frutti del mistero chiamato uomo.
Io amavo ascoltare la canzone “Un fiume amaro”, nella traduzione dal greco proposta dalla voce di Iva Zanicchi. E mi crogiolavo così, in quella età incerta che chiamano adolescenza, dove non si è ancora uomini e non si è più ragazzi. E si vorrebbe essere un altra persona, da un’altra parte della terra, in un luogo ideale, quello dei sogni che non si avverano mai, ma senza dei quali non possiamo vivere.
Tra i brani stranieri preferivo “My sweet Lord!” di George Harrison, e mi chiedevo chi fosse mai quel Dio cantato dal più mistico dei Beatles; sicuramente era un Dio, pensavo io nella mia ignoranza, diverso da quello dei papi del nepotismo rinascimentale, grandi predicatori e voluttuosi razzolatori, un dio diverso da quello che risiedeva nel Vaticano dei mille misteri e dei ricchi cardinali; delle chiese e delle prediche così distanti da noi poveri giovani, in cerca di libertà e piacere a basso e pronto consumo. Forse era un Dio permissivo e generoso, che riusciva a parlare e a ispirare i musicisti del movimento rock; un dio giovane e moderno, non un vecchio barbone semiaddormentato nei cieli che non riusciva a vedere le storture e le ingiustizie del mondo; che non riusciva a fermare le sempiterne guerre dell’uomo, le sue avidità, la sua prepotenza, la sua violenza.
Beata presunzione della prima età! Come se i peccati dell’uomo non fossero un frutto dell’uomo stesso, ma fossero da addebitare a un’entità esterna e responsabile delle nefandezze umane!
Ma in fondo la canzone che ascoltavo con maggiore coinvolgimento emotivo, in assoluto, era “Samba pa ti” di Carlos Santana (un altro mistico che cercava Dio). Con le sue note vibrava il mio stesso corpo al contatto con altri corpi, nei balli che riuscivo a strappare nelle balere di provincia, dove la domenica cercavo di dimenticare i miei enigmi esistenziali.
Al compimento del ventunesimo anno, come ho già detto, mio fratello Pietro Marino, in aperto dissenso con la strategia di espansione aziendale che nostro padre aveva perseguito per anni, se n’era andato via di casa per tentare, in solitario, la sua fortuna commerciale.
La sua ribellione, che in realtà aveva serpeggiato sotto traccia sin da quando mio padre lo aveva ritirato dalla scuola pubblica per avviarlo alla sua scuola di orologiaio, era esplosa apertamente, per una magica e strana coincidenza, proprio nel 1968. In quell’anno infatti il mio fratello maggiore aveva compiuto i 21 anni (che all’epoca segnavano per legge il compimento della maggiore età). A parte quella coincidenza, mio fratello Marino al movimento rivoluzionario ’68 non sembrava attribuire troppa importanza, se non per criticarlo e addirittura esecrarlo per i suoi eccessi .
La sua ribellione non era infatti contro una società che, spinta da quelle forze misteriose che l’uomo ha imparato a etichettare come rivoluzioni e progresso, la sottopongono a continui e perenni trasformazioni, ma bensì contro l’autoritarismo paternalistico di nostro padre. Che poi, se vogliamo, a ben vedere, era un modo pragmatico e personale di fare il ‘ 68. Che altro non fu quel movimento, se non una ribellione contro l’autoritarismo e il potere costituito a favore di una maggiore libertà e di una più autentica democrazia?
Pur tuttavia mio fratello a parole e nei fatti aborriva la protesta giovanile; denigrava i capelloni, propugnava sonore legnate per gli studenti e i lavoratori scansafatiche e per i sindacalisti che li appoggiavano nei continui e rumorosi scioperi; rifuggiva dalle mode che tentavano e di fatto omologavano tutto e tutti, quasi imponendo comportamenti consumistici di massa; odiava la sinistra extraparlamentare e i comunisti ortodossi allo stesso modo; detestava le femministe, per non parlare delle droghe e di ogni altra forma di evasione che andasse fuori dai binari tradizionali.
E non di meno, gli slogan della sua lotta contro l’autorità paterna, erano stati ”Viviamo in un regime di libertà!” “Il sabato e la domenica li voglio liberi!” “Il ventennio è finito da un pezzo!” e così via protestando.
Nell’estate del ’71 mio fratello Marino aveva abbandonato il vecchio locale di via Cagliari, dove io, in un recente passato, gli avevo fatto compagnia e si era trasferito in via Roma.
Il cambio di negozio non giovò soltanto agli affari (che subirono un notevole incremento) ma anche e soprattutto all’umore e alla salute di mio fratello che parvero rifiorire da quelle lande di depressione e malessere in cui sembravano essere scivolate dopo la sua grande ed eclatante rivolta contro i disegni egemonici di mio padre.
I clienti entravano ed uscivano in continuazione, soprattutto la sera. Mio fratello vendeva con discrete capacità ed io lo affiancavo per vedere che qualche mariuola dalle mani svelte, approfittando magari di un suo momento di distrazione, facesse sparire qualche oggetto d’oro.
-”Stai attento soprattutto se vedi qualche avvenente ragazza che mette in mostra le tette!” – soleva ripetere mio fratello per darmi la carica.
Quando vi era più di un cliente anche io ero autorizzato a servire al banco, sia per la vendita di oggettistica minuta, sia per sostituire un cinturino o altre facili operazioni.
Il periodo più calmo era a fine mattinata. Il negozio chiudeva alle 13,00 ma alle 11,30 in giro non si vedeva molta gente. Anche a Samassi, come in tutti i paesi a vocazione agricola della zona, il pranzo è rigorosamente previsto alle 12,00.
Mio fratello ne approfittava per fare le riparazioni.
Si accomodava di buona lena al moderno banchetto da lavoro in legno, che aveva una serie di cassetti laterali di diverso spessore, un ripiano centrale, con rientranza a mezzaluna, illuminato da una lampada alogena e con un reparto a scomparsa, sottostante, che conteneva l’attrezzeria mobile di uso comune: l’apricassa, un paio di cacciaviti, le pinze a becchi tondi, la lente d’ingrandimento, l’estrattore per vetri, lo stantuffo, la spazzola; le pinzette finissime, gli oleatori, le boccette degli acidi, del grasso e dell’olio stavano sul ripiano rigido oppure protetti nei cassetti, comunque sempre chiusi dalle apposite protezioni. E naturalmente vi era tutto il necessario per le sostituzioni e i ricambi di routine per gli orologi meccanici di allora: corone, alberi e molle di carica; vetri infrangibili; assortimento di assi per bilancieri di orologi; un vasto assortimento di cinturini, sfere delle ore, dei minuti e dei secondi e una infinità di ansette, viti, ingranaggi, rocchetti, perni e mollette a volte quasi invisibili a occhio nudo.
Io lo guardavo affascinato, come avevo fatto qualche anno prima al seguito di mio padre. Era preciso e delicato esattamente come il suo maestro. Solo che al contrario di lui, mio fratello amava chiacchierare durante il lavoro di riparazione al banco (a parte in quei rari momenti topici in cui il lavoro richiedeva un’applicazione particolare e massimo silenzio).
Se era di malumore mi parlava della sua infanzia disgraziata, di quanto avrebbe voluto studiare invece di essere stato brutalmente messo a bottega; degli errori di mio padre che non era stato capace di costituire una vera società familiare a causa del suo carattere dispotico e poco comunicativo; dei suoi amici, tutti sfortunati e pieni di problemi; e di donne.
In fatto di donne, mio fratello era un grande esperto; si prodigava infatti in un vero profluvio di pillole di saggezza sulla materia: a cominciare dal carattere delle donne e sulla loro psicologia instabile e umorale; e sulle loro apparenti virtù di castità e ritrosia; sulla inutilità di stabilire con loro relazioni stabili e sulla convenienza a farsi delle avventure, senza scrupoli e senza rispetto. Aveva in generale poca stima del sesso femminile; alcune categorie sociali erano da lui etichettate come poco di buono, da evitare come la peste: erano le parrucchiere e le infermiere, a suo dire, tutte ragazze di facili costumi, da non considerare per eventuale relazione stabile, tutt’al più, se fossero state “bone”, da inforcare e via. Mi raccomandava di non lasciar correre le numerose occasioni che, fortunato com’ero, lui non si sarebbe certo fatto sfuggire, nel mondo corrotto e libertino della scuola, dove le donne cercavano una cosa sola; e bisognava dargliela! Lui sì che avrebbe provveduto alla grande! E guai se io mi fossi tirato indietro.
Io avrei preferito dei consigli più pratici, magari su come corteggiare una donna, come conquistarla, su quale fosse stato l’approccio più corretto per entrare in quel mondo femminile così ricco, per me, di attrattiva, di fascino e di mistero; ma mio fratello era un fiume in piena e non sembrava attribuire alla psicologia un ruolo rilevante; le donne, secondo lui, erano delle bambole da conquistare, da trombare e da mollare.
Oggi capisco che quelle sue contumelie erano il risultato di tutte le delusioni che lui aveva avuto nei suoi rapporti con il gentil sesso.
Perché queste delusioni gli fossero occorse non so spiegare nel dettagli, perché lui non si confidava con nessuno sulle sue vicende private.
Posso però supporre che il mio caro e sfortunato fratello sia in qualche modo rimasto vittima della sindrome del bravo ragazzo di cui le donne sembrano essere, a loro volta, vittime (qualcuno la chiama la sindrome della crocerossina; non so però se i due paradigmi affettivi coincidano davvero).
E’ noto comunque che le donne siano attratte più dalle simpatiche canaglie che dai bravi ragazzi. Mio fratello era sicuramente un bravo ragazzo, affidabile, con un’ottima posizione economica eppure con le donne non ebbe mai fortuna.
Guardandomi in giro ho visto spesso delle ragazze molto carine e pulite, accompagnarsi con dei ceffi dall’aspetto poco raccomandabile. Mio padre, a tal proposito, ripeteva spesso che se fosse nato donna, sarebbe morto vergine, perché mai si sarebbe fatto toccare da certi elementi maschili, neppure con una canna di venti metri!
Io allora vedevo le donne come delle dee, da adorare e venerare; sicuramente da rispettare e da amare, ma mai da considerare come una merce di consumo, da pagare per delle prestazioni sessuali; e neppure dei corpi di cui godere, per poi scappare, in cerca di altro piacere, come sembravano suggerire le teorie di mio fratello ma anche di tanti altri uomini di mentalità maschilista.
Eppure questa attrattiva che i cattivi esercitavano sulle donne; questa loro attitudine a legarsi sentimentalmente con dei caratteri arroganti, con degli spavaldi, quando anche non perfino delinquenti e malvagi, per me rimane un mistero irrisolto e, forse, irrisolvibile.
Può darsi che sia soltanto un problema di sicurezza interiore. Ho avuto modo, in periodi diversi della mia vita, di appurare che le donne sono attratte da un carattere stabile, fermo e sicuro; magari per contrasto con il loro carattere, in fondo volubile e, se non altro, fisicamente più fragile. E a volte, ai loro occhi, un bravo ragazzo è soltanto un carattere insicuro e fragile (e si sa che i simili si respingono);mentre gli opposti si attraggono; ed ecco spiegata la loro attrazione per i supermachos motorizzati, che vivono ai margini della legge e che non hanno altre sicurezze nella vita che il loro ego smisurato e la loro boria.
Eppure i femminicidi che si susseguono oggi a ritmo impressionante, mostrano al contrario una grande fragilità psicologica nei maschi e allo stesso tempo sembrano dar ragione però a una certa attitudine all’autodistruzione ed ai guai che le donne hanno sempre mostrato di avere, sin nella scelta dei loro uomini.
Così passò anche quell’estate del 1971, tra grandi discorsi, inestricabili misteri e canzonette facili che mio fratello metteva alla radio in sottofondo, quando non ascoltava chiamate Roma 3131 o altri programmi radiofonici pseudo-culturali.
Tra le canzoni che più ho amato, in quell’anno, oltre a quelle già menzionate nei capitoli precedenti, mi piace ricordare “Ed io tra di voi” e “L’istrione” di Charles Aznavour; “Donna felicità” dei Nuovi Angeli; “Pensieri e parole” del grande Lucio Battisti (e di Mogol Giulio Rapetti).
Quando tornammo a Cagliari, preludio all’inizio dell’anno scolastico, imparai da un amico quattro accordi alla chitarra ( Do, La minore, Re minore e Sol). Davvero ben poca cosa se si pensa che in questo stesso anno i Led Zeppelin pubblicano “Stairway to Heaven”, David Bowie “Ziggy Stardust” e i Rolling Stones “Brown Sugar”.
Ma io li avrei conosciuti soltanto qualche anno più tardi. Quell’anno conobbi “Jimi Hendrix” ed il suo meraviglioso “Electric Ladyland” grazie a uno scambio che feci con un amico che nel darmi la cassetta di Hendrix in cambio di una che io avevo di Orietta Berti (non ne ricordo il titolo, né come l’avessi avuta, perché in realtà non l’avevo mai neppure ascoltata) mi disse di pensarci bene, perché stavo facendo il peggiore affare della mia vita e che lui era disposto a darmela senza niente in cambio, perché comunque lui ne avrebbe guadagnato qualcosa già nel liberarsene.
Io ascoltai per anni, in estasi, quelle meravigliose composizioni musicali, quella magica chitarra, quella voce che sembrava arrivare da un altro mondo. Solo più tardi scoprii che dietro quelle composizioni musicali, così come per quelle dei Led Zeppelin, dei Rolling Stones, di David Bowie e di tanti altri artisti della musica rock c’era davvero un altro mondo, fatto di esperienze vissute attraverso il consumo di sostanze stupefacenti, dalle più leggere e forse innocue, a quelle più pesanti e micidiali. Tanto ciò è vero che molti di questi artisti sono morti per l’abuso di queste sostanza stupefacenti. Ma all’epoca io ero davvero all’oscuro di queste esperienze, che feci soltanto più tardi negli anni, quando mi recai a Londra, in cerca neppure io saprei dire di cosa. E anche di questo avrò modo di parlare in seguito al paziente ed affezionato lettore, se vorrà continuarmi a seguire.
Io però, all’epoca, non vedevo l’ora di tornare a scuola. Lì, più che in casa mia, trovavo la mia dimensione ideale.
E poi adesso mi aspettava la quarta. Stavo diventando grande, anche se non me ne accorgevo.
Leggi il testo integrale di Memorie di scuola di Ignazio Salvatore Basile, acquistando on line(c/o Mondadori store, Feltrinelli, IBS, Libreria Universitaria, Amazon ecc.) oppure in libreria il volume edito da Youcanprint ISBN 9788827845486. Il romanzo è disponibile anche in formato e-book nel sito della casa tramite il link sottostante.
https://www.youcanprint.it/biografia-e-autobiografia-generale/memorie-di-scuola-9788827845486.html